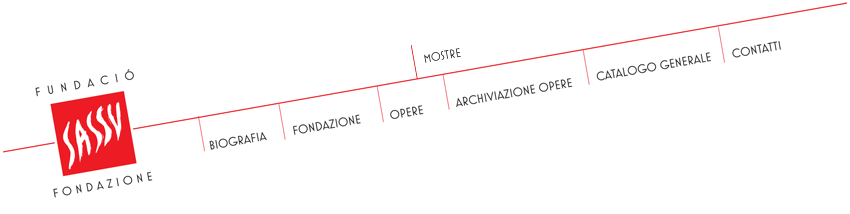Da molto tempo avevo in mente di dipingere il quadro che intitolai poi Ciclisti. Pensavo a un'opera grande, con una composizione di giovani ciclisti alla partenza d'una gara. Già avevo ultimato un altro dipinto, un gruppo di giovani corridori in un paesaggio di periferia (a Milano, fra via Sardegna e via Washington), ma non ero soddisfatto, perché quel lavoro risentiva troppo di certi criteri volumetrici di eredità futurista. E io invece cercavo qualcosa d'altro, di più vivo, di più legato alla vita d'ogni giorno. Volevo meglio risolvere il problema dei raggi delle ruote e di tutti gli altri elementi: non già fredda riproduzione astratta, anzi, compiuta in ogni riferimento, ma con quei valori di movimento che sentivo dovessero animare le figure, che erano in definitiva quelle di persone che conoscevo, coi loro caratteri espressi in gara, coi loro volti.
In vista dell'opera alla quale pensavo, avevo già fatto disegni e schizzi preparatori, ma non avevo una tela grande, delle dimensioni desiderate. Come avrei potuto procurarmela? Poi facevo tra me i conti con un altro problema, che rimuginavo più o meno in questi termini: «L'asfalto della strada è nero, e questa è la realtà; ma quando si fatica in corsa, con la testa abbassata sul manubrio, gli occhi socchiusi del ciclista filtrano il sangue delle palpebre, e allora la strada diventa rossa. Dunque lunghe strisce, lunghe pennellate rosse».
Erano anni in cui ci s'incontrava nei caffè e, come racconterò più avanti, il caffè era un universo pittorico e poetico. Spesso andavo a trovare Edoardo Persico, che frequentava l'Alemagna, all'angolo di via Torino con via Cordusio, e si parlava di tante cose. Lui mi raccontava della sua vita e delle sue esperienze, della Torino di Casorati e del Gruppo dei Sei, e io ascoltavo. Ascoltando mi sentivo differente, povero com'ero, senza colori e senza tele, con quelle mie idee che si dilatavano nell'immaginazione, differente anche dall'amico Persico e dagli amici Birolli, Manzù, Tomea e Grosso. Per più di una volta spiegai a Persico come avrei voluto dipingere i Ciclisti e ripetutamente lo misi al corrente dei problemi tecnici di esecuzione, come li avrei risolti e perché. Fino a quando un giorno sbottò: «Ma smettila di raccontarci questo benedetto quadro! Deciditi una buona volta a dipingerli, questi tuoi Ciclisti!». Mi alzai indispettito e senza salutare scappai via, pieno di rabbia e di vergogna, ferito dall'uscita di Persico, che però mi voleva bene e aveva ragione. Non so come, trovai i soldi per tela e telaio e con i colori mi arrangiai preparando una tempera a cera; anzi, alcune figure le dipinsi quasi ad encausto. Figure che erano poi ritratti, perché infatti sulla sinistra compariva mio fratello Cecchino, più in là il corridore Pozzi della «Legnanese», il De Carli e il grande Binda con una maglia azzurra quartata di bianco e di rosso, nonché le sembianze di altri amici ancora, con i quali si correva per le strade di Lombardia.
Lavorai in una tensione emotiva mai provata prima. Dipinsi, all'inizio, avendo appoggiato la tela sul mobile toilette di mia madre, in uno spazio ristretto, davanti al letto dei miei genitori. Poi mi spostai col quadro in un'altra stanza e, quindi, in un'altra ancora. Ero come posseduto da quel che dovevo fare, mi sentivo in lotta; mio padre e mia madre, colpiti dall'intensità di quel momento creativo, mi lasciarono lavorare tranquillo. Forse il quadro non era ancora finito quando lo feci vedere a Persico, che restò impressionato; quindi lo mostrai a Raffaello Giolli e in seguito lo tenni con me, esponendolo una sola volta, perché mi piaceva che fosse avvolto nel mistero e che si parlasse dei miei Ciclisti come di un'opera esclusiva, diversa dalle altre (Guttuso, che la vide, ne parlò in maniera entusiastica). (Aligi Sassu, Un grido di colore, Todaro Editore, 1998)
|